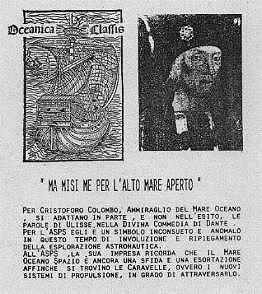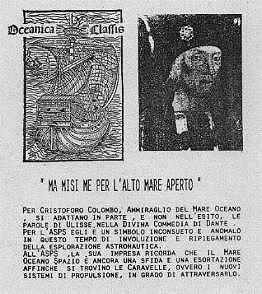Stato Astronautica
Lo Stato Attuale dell'Astronautica
Il 21 luglio 1969 Neil Armstrong imprimeva la prima orma umana sul suolo lunare. L'impresa era esaltante e giustamente esaltata dai mezzi di informazione di tutto il mondo con titoli adeguati. In molti di essi traspariva l'orgoglio di appartenere ad una razza che era riuscita a liberarsi dal vincolo della superficie planetaria e per tale razza sembravano schiudersi orizzonti illimitati ed impensati solo venti anni prima; lo spazio cosmico, nonostante che alla luce della ragione il tragitto percorso potesse considerarsi infinitesimo rispetto alle distanze galattiche, appariva a portata di mano; la fantasia si sbizzarriva in voli sempre più arditi e senza confini, corroborati dai positivi risultati delle successive missioni già previste nei programmi del progetto Apollo.
Oggi, non solo lo spazio cosmico non è stato conquistato, non solo Marte non è stato colonizzato, non solo l'uomo non ha impiantato una base stabilmente abitata sulla Luna, ma è anche ben lontano dal poterci ritornare. Anzi, ansima ed annaspa tra i problemi legati alla semplice permenenza in orbita intorno al pianeta di origine, ben misero risultato se comparato con i proclami di onnipotenza apparsi sulla stampa del 22 luglio di quello stesso anno.
A che cosa è dovuta tale involuzione?
Non certamente alla impossibilità tecnica: ciò che è stato fatto una, due tre volte, è sicuramente ripetibile ed in meglio. Vi sono documenti che testimoniano come l'astronautica pioneristica dei primi anni 50, Werner Von Braun tanto per intenderci, fosse in grado di portare una spedizione di una dozzina di uomini su Marte senza particolari problemi se non quello di stabilire chi dovesse pagare il conto. Ebbene il punto è tutto qui, oggi più di 40 anni fa.
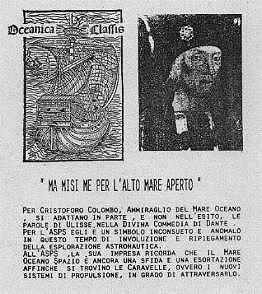
Per chiarire il concetto è bene ricordare che la tecnica missilistica che si basa sulla propulsione chimica, vale a dire quella utilizzata fino ad oggi, per quanto sviluppata, mostra la corda su alcuni limiti ben precisi:
* i costi intrinseci della stessa, legati all'alto costo dei carburanti;
* la relativamente bassa velocità che comporta, soprattutto alle missioni con equipaggio, spese di sicurezza e di sopravvivenza nello spazio che si pongono in relazione di progressione esponenziale con la durata crescente del viaggio;
* l'abnorme sproporzione tra il peso del carico pagante rispetto a quello del lanciatore alla partenza, quantificabile intorno all'uno per mille per ipotetiche missioni di andata e ritorno verso Marte, ed avremo il quadro completo della situazione.
Ora, in un simile ambiente di costi iperbolicamente crescenti, di bilanci nazionali sempre più ristretti e di tagli di investimenti sulle attività spaziali a favore di altri settori che si ritengono socialmente più utili, si riuscirà a meglio comprendere le ragioni di quello che, dopo l'euforia iniziale, oggi non può essere definito altro che un fallimento. Basti pensare che per portare con lo Shuttle in orbita bassa 1 kg di carico commerciale la tariffa si aggira sui 45 milioni di lire, per immaginare che nessun ente né pubblico né privato si azzarderà a rischiare somme da capogiro per permettere ad un altro Aldrin di fare quattro passi, praticamente inutili, sulla Luna o, peggio, su Marte. Ed i 45 milioni sono la tariffa dello Shuttle, che è un mezzo parzialmente recuperabile operante su di un'orbita bassa!
Di qui la ricerca di artifici vari per ridurre i costi.
Se nel campo delle missioni interplanetarie si va sulla strada della fionda gravitazionale, che obbliga peraltro alla contropartita di un allungamento a dismisura dei tempi di volo e quindi a rendere sempre più critiche ipotesi di missioni umane, nel settore tecnico si è alla ricerca spasmodica del risparmio sui materiali con risultati spesso tragici.
Apollo 13 è stato un caso risoltosi senza danni grazie anche ad una buona dose di fortuna, ma non altrettanto può dirsi per l'equipaggio dello Shuttle Challenger. E se va bene per le persone, i casi di perdite economiche sulle apparecchiature sono continui. Bastino solo pochi esempi recenti e fra i più noti alla pubblica opinione: la missione Mars Observer, i due satelliti al guinzaglio Tethered. Tuttavia in questo settore tutte le nazioni portano il loro contributo. Gli Europei per loro parte hanno conosciuto con Hermes, fratello povero e modesta copia dello Shuttle, un aborto inglorioso e con Ariane i loro guai prima ancora del recente disatro di Ariane 5. Molti disastri sono passati e continuano a passare sotto silenzio nell'area orientale.
I Russi hanno perso Phobos I e Phobos II ma soprattutto hanno visto i loro astronauti al limite della fame sulla stazione orbitale Mir perché non avevano più i soldi per farli ritornare indietro; se la loro farsa non ha avuto un diverso epilogo è stato grazie ad una colletta internazionale. In Cina ed in India i lanciatori che esplodono con il loro carico di migliaia di miliardi sono di più di quelli che riescono a decollare. Lo stesso Giappone, nonostante la fama di precisione ed organizzazione, non è esente da eclatanti fallimenti. Infine le agenzie spaziali di altri paesi, Australia, Brasile e compagnia, sono poco più che patetici spettri.
In questa atmosfera di generale disimpegno, non si può non rammaricarsi della grande, meravigliosa occasione fallita che l'impresa di Apollo 11 sembrava potesse concederere all'umanità. A parte il mero e glorioso galoppo fra le stelle, era lecito ipotizzare che molti dei grandi problemi che oggi ci affliggono, ed in futuro affliggeranno i nostri figli, potessero trovare nell'esplorazione spaziale, se non una soluzione radicale, almeno un sicuro rimedio o semplicemente uno spunto per ulteriori interventi: immediata applicazione nella ricerca scientifica e tecnologica; sfruttamento energetico ed industriale degli asteroidi o dei pianeti di tipo terrestre; soluzioni radicali di molti problemi di inquinamento; inferiore assillo dell'incubo della sovrappopolazione. Tutte ipotesi realistiche anche se, alcune, di lungo termine.
Orbene, tutto questo rimane oggi confinato nella fantascienza, e tale rimarrà anche in futuro se l'umanità non riuscirà a cambiare radicalmente la tecnologia delle missioni spaziali, liberandola dai limiti imposti dalla propulsione chimica a razzo.
Per indicare le cose con il loro termine esatto, ci troviamo in un periodo di stallo con il rischio di un'ulteriore involuzione che determini, in tempi piuttosto ristretti, la chiusura definitiva dei battenti delle agenzie nazionali e quindi delle residue attività spaziali di tutto il mondo. I voli saranno sempre più limitati verso il settore commerciale ancora pagante, gestito quasi sicuramente e solo da società private, nel campo dei lanci sub-orbitali, orbitali o, al massimo, geostazionari, per telecomunicazioni, scienze sociologiche, settori militari e previsioni del tempo.
La grande vagheggiata epopea spaziale rischia di essere tutta qui.
Top